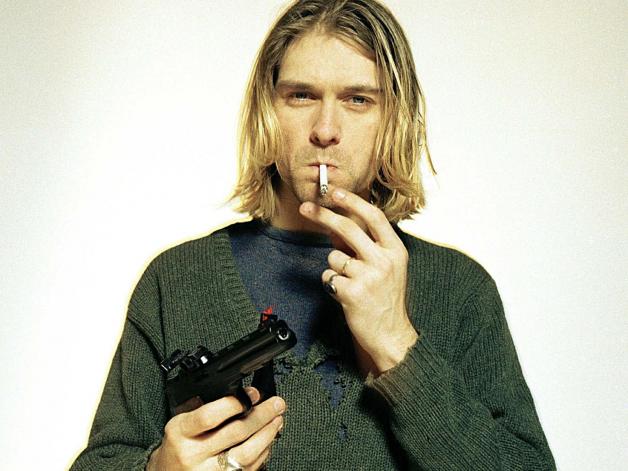Intervista di Giorgia Basili
Abbiamo incontrato Raffaella Perna, docente, critica e curatrice specializzata nell’Arte del secondo cinquantennio del Novecento, conoscitrice soprattutto dei rapporti tra arte e fotografia, scandagliati a fondo anche alla luce dello stretto intreccio con le lotte del Movimento Femminista.
Giorgia Basili: Tu sei una storica dell’arte esperta di artiste degli anni Settanta e non solo… ti sei soffermata, da una parte, sui rapporti tra arte e fotografia, dall’altra, hai indagato specificatamente arte e fotografia legate al movimento femminista. La nostra intervista verterà proprio su questo movimento, iniziamo con le mostre che hai curato, che si concentrano sui rapporti tra arte e fotografia, in generale, e sull’arte e il femminismo, in particolare… mi viene in mente la mostra presso la Casa internazionale delle donne quando hai curato, nel 2022, a Marzo “L’oggetto femminista” con una personale di Lydia Sansoni e durante la diciassettesima biennale delle donne a Ferrara nel 2018 la mostra dedicata a “Ketty la Rocca 80. Gesture, Speech and World” insieme anche a Francesca Gallo… se ci vuoi fare un po’ una panoramica del tuo percorso come curatrice.
Raffaella Perna: grazie per l’opportunità e grazie per l’intervista. La mostra alla Casa Internazionale della Donna è nata su richiesta di Giovanna Olivieri, presidentessa di Archivia, un centro formidabile per ciò che riguarda lo studio delle donne. All’epoca, Lydia Sansoni era viva… è morta subito dopo la mostra, aveva 92 anni. Un’artista lasciata ai margini del sistema dell’arte, anche perché lei stessa non aveva questo desiderio così forte di entrare all’interno di alcuni meccanismi del sistema artistico. Ha sempre cercato di utilizzare le sue opere e le sue illustrazioni per la lotta, ha lavorato anche come fumettista per una rivista di sole donne che si chiamava “Strix”, una delle primissime riviste dedicate al fumetto femminista in Italia quindi ha messo un po’ al servizio della causa femminista e della lotta politica la sua capacità creativa. Per me, è stata un’occasione molto interessante, non la conoscevo nonostante mi occupi di quest’ambito di ricerca da tanti anni, per me è stata una scoperta che devo alla Casa Internazionale delle donne …mentre il lavoro su Ketty la Rocca è un lavoro più legato all’attività di ricerca universitaria perché nasce da un progetto di avvio alla ricerca che avevo vinto nel 2012 e poi, dopo un po’ di anni, abbiamo realizzato con Francesca Gallo un libro, da lì, i familiari di Michelangelo Vasta che dirige l’archivio di Ketty la Rocca ci ha invitate a realizzare la mostra in occasione della Biennale della donna. Anche quella è stata un’opportunità interessante perché mi sono confrontata con le tante donne che gestiscono questa manifestazione che ormai va avanti dagli anni Ottanta ed è un punto di riferimento importante per la storia delle donne in Italia. All’interno di questa biennale, sono state curate veramente mostre importanti e poi mi ha dato l’occasione di conoscere meglio il lavoro di Ketty la Rocca che ho potuto poi approfondire ulteriormente per una mostra più recente da Camera a Torino, concepita in maniera specifica sul rapporto tra Ketty la Rocca e la fotografia. Sono due mostre personali, quindi, da un certo punto di vista, hanno un’elaborazione per certi aspetti più semplice… invece, il confrontarmi ad esempio nel “Soggetto imprevisto” con l’opera di più di 100 artiste e 300 opere è stato più impegnativo: ho dovuto organizzare il display della mostra, trovare i contatti, creare all’interno dello spazio espositivo un dialogo tra queste autrici…queste sono alcune delle mostre che ho curato.
Giorgia Basili: Femminismo, identità, esplorazione del sé: sono temi centrali che si intrecciano nelle opere di molte artiste italiane attive negli anni 70, come hai già chiarito in un’intervista. Quali sono, secondo te, le differenze poetiche e stilistiche più significative tra l’opera di Ketty la Rocca, Tommaso Binga e Lucia Marcucci, quali, invece, sono dei punti di convergenza?
Raffaella Perna: sì, diciamo che l’esplorazione del sé, l’indagine sull’identità e sul corpo delle donne è centrale per l’arte degli anni 60 e 70 in Italia. Sicuramente, artiste come Ketty la Rocca, Lucia Marcucci e Tommaso Binga sono autrici che hanno dei punti di contatto fortissimi, non soltanto dal punto di vista storico, perché hanno collaborato in tantissime occasioni, ma anche dal punto di vista del linguaggio… Ketty la Rocca e Lucia Marcucci, soprattutto negli anni 60, nel periodo della fase legata al Gruppo 70 e alla poesia visiva, hanno sicuramente delle affinità, anche dal punto di vista stilistico-formale molto forti, perché entrambe utilizzano e riprendono dalle prime avanguardie la tecnica del collage, quindi, questo uso straniante di immagini e parole; entrambe esplorano la dimensione della donna, della casalinga, della lavoratrice all’interno della società tardo capitalistica. Negli anni Settanta e fino alla morte di Ketty la Rocca, quindi nel 76, come dire, in qualche modo, la distanza dal punto di vista della poetica aumenta perché soprattutto Ketty la Rocca si dedica al recupero della corporeità, del linguaggio primigenio, della performance, una performance anche diversa rispetto a quelle più multimediali, più multisensoriali degli spettacoli realizzati da Lucia Marcucci nel decennio precedente. Tommaso Binga, diversamente da loro due, probabilmente ha esplorato molto di più l’aspetto fonetico, quindi la sonorità e l’aspetto fonetico. Il corpo della parola, in questo senso, della parola parlata e della parola agita, è un elemento più caratteristico dell’opera di Tommaso Binga sicuramente, anche se, anche nel caso di Tomaso Binga e Ketty la Rocca, soprattutto per ciò che riguarda le opere legate alla scrittura de-semantizzata, questa scrittura non più leggibile, che si fa disegno, che si fa linguaggio non più comunicante, c’è sicuramente un debito rispetto all’opera di Ketty la Rocca nelle riduzioni, e quindi ci sono dei punti di contatto comunque forti alla base di tutte e tre queste autrici perché sono tre autrici che hanno veramente riflettuto a fondo sulla condizione delle donne all’interno del sistema artistico e dell’immaginario visivo, della cultura visiva degli anni Sessanta e Settanta.
Giorgia Basili: infatti, qual è – penso a persone che ci stanno ascoltando e vedendo e non sanno poi quali siano proprio i linguaggi espressivi di queste artiste – anzi quali sono, secondo te, a livello esemplificativo, tre opere, una ad artista…
Raffaella Perna: “Sana come il pane quotidiano” è un collage iconico di Ketty la Rocca in cui l’artista mostra una donna giovane e bella, disponibile, quindi lo stereotipo della donna, l’immagine della donna diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, insieme però a delle parole che si riferiscono alla cultura cattolica… quindi c’è questa frizione tra l’immagine e, invece, quella che è la cultura patriarcale che contraddistingue la società. Per ciò che riguarda Lucia Marcucci, ci sono tanti collage che potrebbero essere presi in considerazione ma, un’altra opera interessante appartiene agli anni Settanta, è databile al ’70: “Ama come lavora”, rappresenta una donna che è, appunto, vista come oggetto di produzione e riproduzione, quindi nella doppia accezione, nel doppio ruolo e nella doppia presenza che la donna riveste all’interno della società capitalista. Mentre, per ciò che riguarda Binga, anche nel suo caso, una delle primissime opere realizzate riguarda la cura del corpo: c’è questa donna inscatolata all’interno di un imballaggio di polistirolo… quindi, da una parte, c’è una sorta di gabbia che è una gabbia fisica – per corrispondere agli stereotipi di bellezza estetica che, appunto, portano una donna a una cura del corpo diversa anche da quella dell’uomo – e, dall’altra parte, c’è questo materiale di scarto, il polistirolo, lo stesso delle scatole da imballaggio, quelle tipiche del supermercato, quindi un’associazione tra il corpo della donna e un oggetto in vendita. Si usa un materiale che era, all’epoca, relativamente nuovo, anche se già esplorato da artisti come Piero Manzoni o come Fabio Mauri a Roma nel ‘68 con l’installazione alla Galleria La Tartaruga, però diciamo sicuramente era un materiale nuovo, legato proprio a quest’idea di consumismo, di scarto veloce…
Giorgia Basili: mi viene in mente anche, forse proprio legandola a questo argomento, Giosetta Fioroni in quell’opera sul voyerismo, con lo spioncino…
Raffaella Perna: …assolutamente, appunto, proprio al Teatro delle Mostre – dove figurava anche l’opera di Fabio Mauri, l’installazione “La luna”- a inaugurare quella rassegna, nel maggio del 1968, c’era stata l’installazione-performance realizzata da Giosetta Fioroni “La spia ottica” in cui il pubblico veniva invitato a guardare un’attrice-performer che, in realtà, non faceva altro che compiere dei gesti quotidiani all’interno della camera da letto di Giosetta Fioroni, riallestita per l’occasione in galleria: è un’azione, un’opera, che in qualche modo gioca proprio e lavora sui meccanismi voyeuristici, su questa idea di vedere il corpo della donna come oggetto reificato… molto interessanti rispetto a quell’opera sono alcune considerazioni fatte da Menna perché sosteneva che tutto, in realtà, si svolgesse fuori: il parlare, l’agire, la festa accadevano fuori da quella stanza. Quindi, è come dire, l’azione si trovava al di fuori di quella che era, invece, la domesticità tipica del del vissuto femminile.
Giorgia Basili: Tu hai scritto anche su Silvia Giambrone e mi vengono in mente anche dei lavori di altre artiste italiane come Chiara Fumai che ci ha lasciati e Vanessa Beecroft… proprio a questo punto ti chiedo, quali sono per te le artiste italiane e internazionali attuali alle quali dovremmo guardare e quali le artiste che, in questo momento, stanno portando sul tavolo dei discorsi essenziali per il Movimento Femminista, per l’identità della donna ma anche dei componenti del gruppo LGBT+ ?
Raffaella Perna: una tra le artiste che mi interessano molto, non dell’ultima generazione, perché ha più di quarant’anni, insomma sono tantissimi anni che lavora, è sicuramente Silvia Giambrone perché è riuscita, in qualche modo, a rileggere tutta quella che è stata dal punto di vista formale-estetico l’eredità dell’Arte Povera ma lo ha fatto con uno sguardo chiaramente legato a problematiche, a questioni sull’identità della donna, sui rapporti interpersonali, sui rapporti di violenza che si collocano o che si svolgono all’interno delle mura domestiche. Ha lavorato su tematiche connesse alla violenza psicologica e fisica, in una maniera però non diretta, non didascalica, non retorica… quindi, una cosa che apprezzo molto sulla sua opera è questa sua capacità di formalizzare poi il lavoro e di ricollegarsi a una storia dell’arte… penso alla sua performance “Teatro anatomico” in cui si fa cucire addosso un colletto ricamato da Nucci, in quel caso la performance fu al Macro… in qualche modo, rilegge tutta una simbologia e una tradizione da Gina Pane – ci sono anche saggi proprio che esplorano il rapporto con Gina Pane – però lo fa in una maniera assolutamente nuova e originale, collegata a dinamiche, come dire, molto contemporanee come la passività, ad esempio come il corpo femminile possa essere reso passivo, non soltanto sul piano fisico ma anche nell’immaginario del vestiario, dell’abito che è un modo di rappresentare se stesse… c’è questo collegamento anche con l’epoca vittoriana che ritorna spessissimo nel suo lavoro e credo che sia insomma un lavoro molto molto interessante, come tutta la serie delle sue sculture con le spine, queste sue sculture che simulano proprio la pelle, l’aspetto dell’epidermide, a volte sembra ci siano delle macchie che solcano la superficie che ricordano veramente i lividi di una violenza, per cui c’è tutta questa tensione che viene generata nelle sue opere o ad esempio nel lenzuolo “Borders” tagliato a metà che ricorda un po’ i lenzuoli usati da Fabbro e da Kounellis, però con questo semplicissimo gesto di tagliare a metà, cucire e ricucire questo lenzuolo di un letto matrimoniale ci fa capire la difficoltà dei rapporti interpersonali…credo che questa sia una sua caratteristica molto importante poi ci sono artiste, in realtà, che… penso a un’altra una fotografa che forse nel campo specifico dell’arte contemporanea è meno nota ma adesso sta avendo un buon momento di visibilità perché le hanno appena dedicato una mostra al Centro Pecci di Prato che è Lina Pallotta. Lina Pallotta è un’artista, una fotografa che ha seguito per tantissimi anni e ha fotografato Porpora Marcasciano, la presidentessa onoraria del movimento italiano transessuali, una figura chiave delle lotte LGBT qui in Italia e ha da poco pubblicato con Nero magazine un bellissimo libro fotografico, un bel libro anche perché non ha a corredo solamente la parte legata alla sua opera ma tutto un materiale archivistico di documenti storici legati al movimento omosessuale italiano, che sono preziosi perché sono utilissimi anche per conoscere questo momento della storia e della politica italiana. Le sue foto sono straordinarie, secondo me, perché non sono foto di denuncia immediate o stereotipate ma si privilegia nel racconto fotografico l’intimità, il rapporto di sorellanza e di amicizia, quindi non soltanto il lato pubblico delle lotte legate al riconoscimento dei diritti LGBTQ+ ma anche questa interiorità. Credo che sia una fotografa da tener sott’occhio, magari meno nota rispetto a Chiara Fumai o alla Beecroft – che hanno un passato, diciamo, hanno avuto un’esperienza breve nel caso di Chiara Fumai, più lunga nel caso di Beecroft ma comunque con molta visibilità -. A me interessa guardare, scoprire, insomma andare a soffermarmi su artiste-autrici che in qualche modo possano ancora essere valorizzate.
Giorgia Basili: grazie, avevamo citato, hai citato, Gina Pane, quindi mi viene in mente che ci sono molte artiste inglesi, americane o comunque internazionali su cui ti sei soffermata durante delle lectures o nelle lezioni durante la tua carriera universitaria a La Sapienza, mi viene in mente Judy Chicago con l’opera dinner party e project, Ana Mendieta, Barbara Kruger con i suoi manifesti, Cindy Sherman con gli untitled film stills o comunque anche Joko Ono, Jenny Holzer, insomma Louis Bourgeoix, ce ne sono tantissime… secondo te, se volessimo in qualche modo ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia dell’arte femminista, quali opere dovremmo considerare e quali artiste…sarebbe bello parlare insieme di dinner party per esempio, dell’opera di Ana mendieta o appunto se hai un’opera in testa anche quella di Martha Rosler sì sì c’è ne vuol parlare
Raffaella Perna: sì anche quest’anno in realtà per gli studenti di Fashion Studies ho tenuto un corso proprio sulla storia dell’arte con una prospettiva di genere, si tratta anche di studenti che non hanno delle nozioni sistematiche di storia dell’arte basilari… quelle che tu hai citato sono artiste estremamente note, alle quali hanno dedicato mostre, libri eccetera…e mi rendo conto che tutto sommato non è detto che tutti le le conoscano, anche se appunto per gli addetti ai lavori sono ormai dei nomi consolidati. Judy Chicago è uno dei nomi fondamentali, anche controversi, perché “Dinner party” è stata un’opera fondamentale, c’è un bellissimo libro di Amelia Johnson – e la mostra sexual politics non nasceva per essere dedicata interamente a lei – che ne ripercorre e contestualizza la storia dell’opera e affronta anche le difficoltà che l’artista ha avuto nella sua realizzazione perché si tratta di un’opera eseguita con una gestazione lunga oltre 5 anni e un numero incredibile di donne coinvolte, circa 400, negli anni dal 74 al 79. La regia e la direzione, la concezione appunto è di Chicago ma poi, in realtà, è un frutto collettivo. Si tratta di un’opera che, attraverso l’uso di questo altare cerimoniale basato su tre ali, ripercorre la storia di 39 figure di donne reali come Virginia Woolf e Georgia O’Keefe o figure archetipiche come la grande idea, figure del del passato al limite tra il mitologico e il reale, provando in qualche modo a raccontare un percorso di empowerment di presa di consapevolezza, di emancipazione femminile, un percorso anche contestabile e controverso, per certi aspetti, perché un’opera del genere prende poco in considerazione, ad esempio, donne afrodiscendenti. Solo uno dei piatti di ceramica inclusi in Dinner party ha come oggetto una donna nera, l’opera risulta comunque legata a uno specifico momento della storia del femminismo europeo e nord-americano, esprime quindi quelli che possono essere i limiti ma anche i punti di forza… i piatti sono decorati con forme che si riferiscono al corpo, central core, immagini di vulve o di fiori o di farfalle che però appunto alludono sempre al sesso femminile… questa connessione tra la biologia e la donna è una connessione problematica, un po’ scivolosa perché in qualche modo sembrerebbe riconfermare lo stereotipo della donna-corpo, donna-natura… delle critiche hanno colpito l’opera negli anni 80, quando la teoria femminista si è sviluppata probabilmente con delle armi anche un po’ più appuntite e affilate… negli anni 70 il fatto già di interrogarsi su questi termini, di cercare di capire quale poteva essere anche, secondo me, è già un traguardo fondamentale. Oggi l’opera è esposta al Brooklin Museum ed è una delle opere cuore di questa collezione. Ana Mendieta è una di quelle artiste che per prime hanno criticato questa poca sensibilità delle donne borghesi, bianche, nordamericane rispetto a un’alterità che è un’alterità non soltanto uomo-donna ma un’alterità che deve tener presente anche problemi legati alla geografia, all’etnia, alla classe…insomma viene introdotta quella che oggi noi definiamo una prospettiva intersezionale. Un’artista come Ana Mendieta sicuramente in questo è stata fondamentale, anche per opere che rimangono ancora oggi sconvolgenti… sono opere molto forti, per esempio, la performance in cui simula ciò che avviene dopo uno stupro: si fa trovare dai suoi compagni del campus universitario senza gli abiti, con la parte inferiore del corpo completamente nuda e ricoperta di di sangue, appoggiata e riversa su un tavolo. Fu un modo molto forte per comunicare quello che è uno dei problemi ancora attuale, legato alla violenza di genere, il problema della violenza sulle donne è una questione durissima purtroppo con la quale dobbiamo confrontarci ancora…
Giorgia Basili: certo, su questa tematica altre artiste hanno focalizzato il loro lavoro, una delle performance iconiche è quella di Marina Abramovic… anche il padiglione statunitense vincitore della Biennale di Venezia con l’opera dell’afroamericana Simone Leigh ci dimostra che siamo sicuramente più attenti a queste tematiche e che ci sono nuove artiste afrodiscendenti che finalmente vengono considerate, come in tutti gli altri ambiti d’espressione, anche se nel mondo dell’arte visiva si fa più attenzione ad artisti che non siano europei o americani. Si sta affermando finalmente uno sguardo più inclusivo di altre culture ed etnie. Visto che citavamo anche prima la Woolf, da “Una stanza tutta per sé” arriviamo a una situazione attuale che sembra cambiata ma che a volte ripercorre dei vecchi pattern mascherati. Secondo te, la situazione è effettivamente cambiata o c’è ancora molto su cui lavorare? È, se così è, quali sono le artiste che stanno puntando proprio su questo discorso?
Raffaella Perna: c’è ancora molto da lavorare credo… non vorrei fare un discorso di quote rosa, di percentuali, però forse anche partire da quelli che sono dati oggettivi può essere utile… ricordo gli studi, pubblicati nel libro “Donne rappresentazione dell’Italia” pubblicato e curato da Caterina Iaquinta e dalla Simoncelli, che riportano delle statistiche legate alla scena italiana pre-covid e mi risulta che ci siano studi più recenti per ciò che riguarda l’Italia… sono dati abbastanza sconfortanti dal punto di vista della presenza delle donne all’interno del mercato dell’arte, per ciò che riguarda i risultati d’asta e anche la possibilità delle giovani artiste di avere delle mostre personali all’interno di gallerie e istituzioni pubbliche. Ecco i dati, non soltanto quelli italiani, anche se andiamo a guardare i report di Art Basel o altri resoconti, ci mettono in guardia che la narrazione secondo cui “ormai le donne hanno raggiunto una parità di visibilità e di possibilità di accesso al sistema” è una narrazione non completamente veritiera e, tutto sommato, anche andando a guardare le collezioni di molti musei ci rendiamo conto che le differenze siano ancora molto forti. La narrazione “va tutto bene” non mi trova particolarmente concorde, nonostante ci sia sicuramente una maggiore possibilità di studiare, raccontare, fare mostre eccetera rispetto a quarant’anni fa. Probabilmente questo è vero, però non è soltanto un problema di numeri, è un problema anche di cosa le artiste devono in qualche modo affrontare nel loro percorso, in quanto il sistema richiede, in realtà, di confrontarsi con dei modelli di competitività, di iper competitività, di iper performatività nel senso proprio di iperproduzione e promozione del sé in senso pubblicitario… un modello ancora molto maschile e molto patriarcale, un modello con cui le donne e le artiste si devono continuare a scontrare, chiedendosi quanto corrisponda loro effettivamente…insomma, credo che alcuni problemi che ci sono stati in passato ancora oggi si ripresentino … naturalmente, rispetto al passato, come dicevi anche tu, c’è una consapevolezza maggiore di un’inclusività e anche gli studi decoloniali hanno portato nuova consapevolezza sul fatto che appunto non esistano soltanto le differenze legate al genere …che vada indagato anche molto a fondo anche come le differenze di partenza, le differenze sul piano dell’economia e della classe sociale possano ancora incidere sul modo di fare arte, sul modo di produrla e veicolarla. Credo che il modello di una buona prassi sia quello di interrogarsi su un sistema artistico da più punti di vista.
Giorgia Basili: Mi vengono in mente ovviamente le Guerilla girls che hanno portato proprio dei dati statistici davanti a un pubblico esterrefatto, perché per la prima volta c’era questo coraggio di urlare un dissenso, appunto le donne non erano rappresentate nelle maggiori collezioni museali e questo era un problema da risolvere e risolvere magari tutti insieme, serviva una risposta immediata… in questo momento, infatti, si stanno riconsiderando delle figure di artiste che non non erano passate inosservate ovviamente prima ma forse rispetto ai colleghi uomini sembravano sempre poco considerate e adesso proprio in questi giorni, un mese fa, sono state inaugurate due mostre importanti dedicate a Lucia Marcucci a Bolzano. La prima si intitola “Poesie e no”, è allestita nei Passages del Museion e si concentra sulle opere e le performance dal 63 al 79; la seconda, invece, “L’offesa” è promossa dalla galleria Ar/Ge Kunst e si concentra sugli ultimi lavori. Su cosa sarebbe bello soffermarsi? Ci sono dei suoi lavori che vogliamo rivedere insieme e che reputi significativi?
Raffaella Perna: ce ne sono diversi, naturalmente…alcuni sono legati a una cosa che m’ha sempre un po’ colpito di Lucia Marcucci: il fatto che avesse una precocissima sensibilità, per ciò che riguarda l’Italia, soprattutto la coscienza ecologica. Ci sono delle sue tele emulsionate in cui compare questa parola “ecologia” nei primissimi anni 70, anche questo insomma il nesso tra la donna e la terra, lo sfruttamento della donna connesso allo sfruttamento del pianeta è un tema, secondo me, molto attuale e in qualche modo che lei ha trattato e affrontato in tempi appunto in cui questo tipo di di contenuti non erano così usuali, soprattutto in maniera così esplicita non erano usuali, all’interno della scena artistica italiana. Ci sono naturalmente altri esempi però, sicuramente, questo aspetto e questa sua capacità di capire e di legare lo sfruttamento di genere su tendenza familiare con quello della terra è secondo me un aspetto importante. Poi ci sono anche altri lavori, a me interessano molto, per esempio, dei suoi lavori forse meno noti rispetto ai collage che consiste in questa serie di impronte del corpo che lei ha fatto nel 78 e che ha esposto, tra l’altro, nella mostra “Materializzazione del linguaggio” curata da Mirella Bentivoglio che, negli ultimi anni, è stata oggetto di un grande rivalutazione. Era una mostra nel 78 che era stata fatta e voluta perché ci si era accorti che la presenza femminile nella rassegna della Biennale di quell’anno era bassissima… si correva il rischio di andare allo scontro con le femministe che, all’epoca, erano vigorose: avrebbero presumibilmente protestato e per riuscire ad arginare il problema, in maniera un po’ strumentale, si apre questa questa mostra. Tuttavia la si apre due mesi dopo l’apertura della Biennale del 78, quindi, in una posizione cronologicamente defilata e anche logisticamente defilata e con pochi mezzi. Mirella Bentivoglio, all’epoca, grazie alla sua rete estremamente capillare di rapporti con poetesse visive di tutto il mondo riesce a metter su una mostra importante. All’epoca, bisogna dirlo, non ebbe questo grande successo, mentre negli ultimi anni è stata veramente oggetto di letture critiche e di mostre. In quell’occasione, Lucia Marcucci presentò questa serie di impronte con il corpo che fanno un po’ il verso a Yves Klein, sono un po’ una parodia delle impronte delle “Antropometrie” di Klein, però, in questo caso, il corpo non è più quello di modelle nude che agiscono come pennelli umani, ma si tratta di un corpo vissuto, agito dall’artista e messo in contrapposizione con parole legate alla cultura patriarcale o anche al marxismo. Ecco perché un’altra delle questioni centrali in quegli anni, pensiamo alle riflessioni su Hegel di Carla Lonzi, è proprio quella di non vincolare la lotta delle donne soltanto all’interno della lotta politica più generale portata avanti dalla sinistra italiana, insomma, quella di scorporarla, o meglio, di cercare di capire quella che è la specificità della lotta di liberazione delle donne. Quelle opere di Lucia Marcucci, secondo me, sono opere interessanti anche perché pongono proprio in dialettica, in tensione, questa corporeità così primaria, così primigenia con idee e concetti legati alla cultura patriarcale.
Giorgia Basili: Benissimo, hai citato “Sputiamo su Hegel” di Carla Lonzi, ti vengono in mente altri testi fondamentali che hanno aiutato sicuramente l’artiste a trovare la strada da percorrere?
Raffaella Perna: beh sicuramente, all’epoca, oltre agli scritti di Carla Lonzi che sono stati fondamentali per una generazione, anche “Speculum. L’altra donna” di Luce Irigaray è stato uno di quei testi fondamentali che ha rimesso un po’ in discussione e ha criticato la lettura psicoanalitica freudiana… naturalmente in Francia, dove è stato pubblicato nel 74, ma anche poi – tradotto da Luisa Muraro nel 75 – in Italia, ha avuto un’eco fondamentale per tantissime artiste italiane. Poi, mi vengono in mente testi più recenti, dagli anni 80 in poi, “L’elogio del margine” (o anche “Insegnare a trasgredire”) di bell hooks (1952-2021), scrittrice afroamericana femminista che poi è scomparsa anche di recente: la sua visione della marginalità non soltanto appunto in un’accezione negativa come impossibilità, ma come spazio creativo come spazio di possibilità, di rivolta scardinante…ci sono poi tantissime altre teoriche e libri fondamentali.
The Guerrilla Girls – Image via Artspace