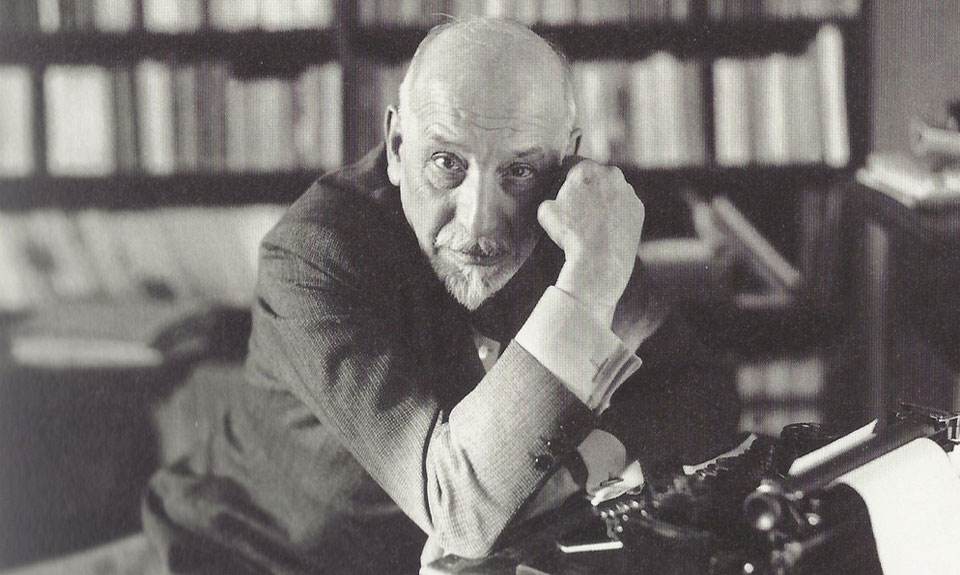L’amicizia è stata da secoli oggetto di riflessione da parte di pensatori e, naturalmente, educatori e ha costituito un notevole capitolo dell’etica. Di solito è stata considerata come un dato esperienziale ricco di vitalità e di significato.
Così, ad esempio, si esprime Cicerone:
«Godo a tal punto del ricordo della nostra amicizia da sembrarmi di essere stato felice solo per il fatto di essere vissuto con Scipione [si tratta di Scipione Emiliano, scomparso da poco]. Insieme abbiamo avuto lo stesso interesse per le occupazioni pubbliche e private, la stessa casa, la stessa esperienza di guerra; e soprattutto la massima armonia dei desideri, delle inclinazioni, delle idee: in ciò è tutta la forza dell’amicizia»
Il primo a trattare esplicitamente e con una certa vastità il tema dell’amicizia fu Aristotele.
È noto come l’etica aristotelica sia contraddistinta dal conseguimento della felicità per mezzo delle virtù, la maggiore delle quali è la theoria, cioè la contemplazione. Però tale conseguimento, che è proprio dell’individuo, non può avvenire senza un rapporto sociale: infatti l’uomo è, per sua natura, un animale sociale (animal politicum). Perciò è nella stessa natura dell’uomo che si fonda la capacità relazionale.
L’uomo, sociale per natura, concepisce dei fini che sono comuni ad altri uomini. Nell’aspirazione a un fine comune è da ricercarsi l’origine dell’amicizia e la sua specificità rispetto ad altri tipi di relazione umana. In concreto: essendo diversi gli scopi comuni che gli uomini possono desiderare di conseguire, se ne deduce che diverso sarà il modo di realizzare la reciproca convergenza. Questa, pertanto, sarà graduale, a seconda dello scopo inteso: il piacere, l’utilità e la virtù. Il tipo di relazione corrispondente alla virtù è il più profondo, perché in tale scopo viene annullato ogni sfruttamento egoistico, ogni strumentalizzazione: ognuno desidera che l’altro sia virtuoso e, quindi, consegua la felicità.
Concretizzando maggiormente questo ragionamento e salendo dal piano della natura a quello delle persone storicamente esistenti, Aristotele dice che l’amicizia è necessaria sia all’uomo che ha già raggiunto la felicità sia a colui che è infelice: nel primo caso perché questa stessa felicità si dispiega in una comunione gioiosa, nel secondo perché l’amicizia costituisce un conforto e un incoraggiamento.
Questa sintesi aristotelica costituisce quanto di meglio il pensiero dell’antichità precristiana ci abbia lasciato riguardo al nostro tema. All’interno di tale sintesi, altri due pensatori hanno accentuato alcuni particolari elementi, restando comunque al di sotto dello Stagirita: si tratta di Epicuro e del citato Cicerone.
La filosofia epicurea affronta soprattutto il problema morale e, in un periodo di notevole benessere e di grande sbandamento culturale (periodo molto simile al nostro … prima della crisi!), ripropone esplicitamente l’eterno problema della felicità. La felicità è l’«atarassia», la calma assoluta e soave, l’assenza della preoccupazione e degli affanni. Il criterio di giudizio per essere sicuri di camminare verso la felicità è il piacere, cioè l’assecondamento metodico e calcolato di ogni tendenza della natura. È a questo punto che s’inserisce la riflessione sul fenomeno dell’amicizia.
«Di tutte le cose che la saggezza offre agli uomini per la felicità della vita, la più grande è il conseguimento dell’amicizia». Dunque l’amicizia è considerata da Epicuro nel contesto della ricerca della felicità e del piacere. Ciò, se da una parte deve rendere cauti nel giudicare Epicuro come un filosofo volgare, dall’altra, rispetto alla posizione di Aristotele, comporta inevitabilmente una diminuzione della purezza dell’amicizia. Difatti Epicuro ben volentieri collega l’amicizia a un certo interesse, una certa utilità egoistica.
Al disinteresse assoluto come nota costitutiva della vera amicizia, invece, ritorna nuovamente Cicerone, che al nostro tema dedica un’intera opera filosofica, il Laelius. In quest’opera il grande oratore romano prospetta anche una definizione dell’amicizia: «omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia et caritate consensio». Se, dunque, la benevolentia e la caritas sono delle qualità inalienabili dell’amicizia, questa non può essere caratterizzata dall’interesse e dal calcolo.
Cicerone, ancor più di Aristotele, accentua l’aspetto sentimentale, parlando dell’amicizia come di un’inclinazione dell’anima congiunta a un sentimento amoroso.